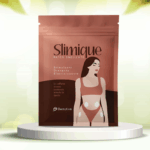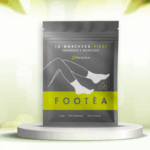Il tema dell’umidità e del suo impatto sul benessere è centrale sia in ambito domestico sia negli spazi di lavoro. Il corpo umano è sensibile ai livelli di umidità relativa: questi influenzano la percezione di comfort, la qualità dell’aria respirata e, in casi estremi, possono anche rappresentare un rischio per la salute. Per determinare quando l’umidità inizia a essere fastidiosa o dannosa, sono stati individuati intervalli ottimali e soglie critiche legate sia alla sensazione soggettiva sia alle evidenze scientifiche.
I valori di umidità ottimali e le soglie di rischio
Il parametro di riferimento è la umidità relativa, che misura la quantità di vapore acqueo presente nell’aria rispetto al massimo che potrebbe contenere a una data temperatura. Nei nostri ambienti è considerato ideale un intervallo compreso tra il 40% e il 60% di umidità relativa, con temperature tra i 18° e i 24° C. Per esempio, con 20 gradi, un tasso di umidità intorno al 50% è ritenuto ottimale per il comfort e la salute umana.Umidità .
Quando l’umidità supera il 60%, iniziano le prime conseguenze concrete: si può formare condensa su superfici fredde (muri, finestre) e, avvicinandosi al 70% o superandolo, il rischio di sviluppo di muffa aumenta notevolmente, con effetti dannosi su materiali e salute, soprattutto per chi soffre di allergie o asma .
Non esiste una soglia universale a partire dalla quale tutti percepiscono disagio, ma secondo autorevoli enti come il NOAA statunitense, già un’umidità relativa del 50% o superiore è generalmente definita “molto fastidiosa”, soprattutto in estate quando le alte temperature compromettono la capacità del corpo di raffreddarsi attraverso l’evaporazione del sudore .
Quando l’umidità diventa fastidiosa o fa male?
L’effetto dell’umidità sulla percezione di benessere dipende in gran parte dalla temperatura ambiente. In inverno, un tasso di umidità sopra il 60% può risultare percepito meno fastidioso, ma in estate anche valori intorno al 50% possono intensificare la sensazione di afa e disagio termico. Più specificamente:
- Sopra il 60%:
il clima diventa troppo umido, aumenta il rischio di muffe, si avverte una sensazione di pesantezza dell’aria e difficoltà di termoregolazione. Con valori dal 65% in su, questi problemi si aggravano notevolmente . - Oltre il 70%:
in ambienti chiusi si sviluppano muffe, le pareti si deteriorano, l’ambiente interno diventa poco salutare, soprattutto per bambini, anziani e persone con patologie respiratorie . - Sotto il 40%:
anche un’aria troppo secca è problematica: si verificano disturbi come secchezza delle vie respiratorie, occhi irritati, pelle screpolata e maggior facilità di contrarre raffreddori .
È importante precisare che l’umidità “fastidiosa” non è necessariamente già dannosa, ma rappresenta una prima soglia di disagio. Il danno vero e proprio si manifesta quando condizioni eccessivamente umide o secche permangono per giorni o settimane.
La correlazione tra umidità e temperatura: quando il benessere è compromesso
La temperatura amplifica la percezione dei danni causati dall’umidità. Questo succede perché il processo di raffreddamento corporeo attraverso il sudore è efficace solo se l’aria circostante è in grado di accogliere nuovo vapore acqueo. Se l’umidità è già elevata, la sudorazione si trasforma in semplice bagnatura della pelle, ma il calore non viene disperso; la persona rimane accaldata e aumenta il rischio di stress da calore, affaticamento, mal di testa e, nei casi più gravi, colpo di calore .
L’intervallo ideale resta tra il 40% e il 60%: poni attenzione però che nelle giornate calde e afose già dal 50% in poi molte persone cominciano ad accusare fatica fisica, difficoltà di concentrazione, sonnolenza e umore peggiorato . Basta un piccolo aumento della temperatura (ad esempio mezzo grado) perché il contenuto di vapore acqueo incrementi del 4%, rendendo l’afa ancora più difficile da sopportare.
Quando la temperatura raggiunge i 35° C abbinata a un alto tasso di umidità, si raggiunge il limite per la sopravvivenza umana: non si riesce più a disperdere il calore corporeo e diventa pericoloso persino stare a riposo . Tuttavia, rischi per la salute si registrano con combinazioni molto meno estreme, soprattutto per i soggetti fragili; basta superare i 30-31°C con umidità sopra il 60% per accusare sintomi di disagio o malessere.
Effetti dell’umidità e come regolarla
Un eccessivo grado di umidità ha ripercussioni su vari aspetti della salute e della qualità della vita:
- Muffa e acari: ambiente ideale per la loro proliferazione, con conseguenti allergie e asma.
- Problemi a pareti e strutture: deterioramento di intonaci, pavimenti, infissi e materiali porosi.
- Disagi respiratori: difficoltà respiratorie, peggioramento di malattie croniche, aumento di infezioni.Umidità
- Sensazione di stanchezza: fatica fisica, difficoltà di concentrazione, sonno disturbato.
Per regolare correttamente l’umidità, si possono adottare alcune strategie pratiche:
- Utilizza regolarmente i deumidificatori o i condizionatori dotati di funzione anti-umidità.
- Aerare spesso i locali, soprattutto dopo la doccia o la cottura dei cibi.
- Prestare attenzione soprattutto alle camere da letto e alle stanze dove si passa più tempo, regolando il clima sugli intervalli raccomandati.
- Chiudi le finestre nelle ore più calde e umide della giornata, aprile nelle ore più fresche.
In conclusione, il benessere si ottiene mantenendo l’umidità tra il 40% e il 60%. La soglia da cui l’umidità è fastidiosa si attesta solitamente intorno al 50%, ma l’effettivo disagio dipende dalla temperatura ambientale e dalla sensibilità personale. Superata la soglia del 60%, oltre ai primi sintomi di malessere, si rischia di causare danni materiali e problemi di salute più importanti, come infezioni, allergie e disturbi respiratori persistenti.